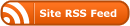In questa pagina sono raccolti tutti gli articoli e i saggi che ho scritto, in ordine cronologico, con i link diretti ai file pdf per leggere i testi completi. Per maggiori informazioni sulle relative pubblicazioni, rimando ai seguenti link: da libri (saggi e articoli pubblicati in volume), da riviste (saggi, articoli, recensioni e resoconti pubblicati su riviste e in rete), testi collettivi (scritti in collaborazione con altre persone) e traduzioni dall’inglese. Nella pagina interventi sono raccolti invece i contributi (in parte inediti) presentati in occasione di convegni e incontri pubblici. Tutti i testi sono pubblicati con una licenza Creative Commons 3.0.
La città postcoloniale di Gabriella Kuruvilla: plurilinguismo e multifocalità nella letteratura italiana contemporanea, in Stefania De Lucia (a cura di), Scrittrici Nomadi. Passare i confini tra lingue e culture, Sapienza Università, Roma 2017, pp. 57-64
con Manuela Coppola, Insegnare genere e “razza”: eredità coloniali e nuove prospettive, in Maria Serena Sapegno (a cura di), La differenza insegna. La didattica delle discipline in una prospettiva di genere, Carocci, Roma 2014, pp. 29-36
recensione di Renata Pepicelli, Il velo nell’Islam. Storia, politica, estetica, in «DWF – donnawomanfemme», n. 99, Confini (in)valicabili, 2013, 3, pp. 73-77
traduzione di Edvige Giunta, Figlie di Persefone, in «DWF – donnawomanfemme», n. 99, Confini (in)valicabili, 2013, 3, pp. 16-25 (ed. or. Persephone’s Daughters, in «Women’s Studies: An Interdisciplinary Journal», Special Issue on Creative Non-Fiction, 33.6, September 2004, pp. 767-86)
con Sara De Simone, Introduzione. Attraversare i confini, in «DWF – donnawomanfemme», n. 99, Confini (in)valicabili, 2013, 3, pp. 4-6 [file pdf]
Quale razza? genere, classe e colore in Timira e L’ottava vibrazione, in Gaia Giuliani (a cura di), La sottile linea bianca. Intersezioni di razza, genere e classe nell’Italia postcoloniale, «Studi culturali», n. 2, agosto 2013, pp. 286-293
I corpi e le voci delle “altre”: genere e migrazioni in Christiana de Caldas Brito e Fernanda Farias de Albuquerque, in Margarete Durst, Sonia Sabelli (a cura di), Questioni di genere: tra vecchi e nuovi pregiudizi e nuove o presunte libertà, ETS, Pisa 2013, pp. 185-208
con Margarete Durst, Premessa. Vecchie e nuove frontiere degli studi di genere. Femminismo, omosessualità, ecologismo, bioetica, in Margarete Durst, Sonia Sabelli (a cura di), Questioni di genere: tra vecchi e nuovi pregiudizi e nuove o presunte libertà, ETS, Pisa 2013, pp. 3-7
con Margarete Durst (a cura di), Questioni di genere: tra vecchi e nuovi pregiudizi e nuove o presunte libertà, ETS, Pisa 2013
Sessualità, razza, classe e migrazioni nella costruzione dell’italianità, in Fortunato M. Cacciatore, Giuliana Mocchi, Sandra Plastina (a cura di), Percorsi di genere. Letteratura, Filosofia, Studi postcoloniali, Mimesis, Milano-Udine 2012, pp. 139-156
La herencia del colonialismo en las representaciones contemporáneas del cuerpo negro femenino, in «Revista Sans Soleil – Estudios de la imagen», n. 4, 2012, pp. 122-131. Traduzione in spagnolo di Ander Gondra Aguirre (ed. or. in «Zapruder», n. 23, 2010, pp. 106-15)
con Manuela Coppola, “Not a Country for Women, nor for Blacks”: Teaching Race and Gender in Italy between Colonial Heritages and New Perspectives, in Teaching “Race” with a Gendered Edge, edited by Brigitte Hipfl and Kristín Loftsdóttir, AtGender, Utrecht & Central European University Press, Budapest 2012, pp. 143-159
Tricolore. Bandiere pericolose, in Sabrina Marchetti, Jamila M.H. Mascat, Vincenza Perilli (a cura di), Femministe a parole. Grovigli da districare, Ediesse, Roma 2012, pp. 279-286
Femminismo nero e postcoloniale, in Maria Serena Sapegno (a cura di), Identità e differenze. Introduzione agli studi delle donne e di genere, Mondadori Università, Roma 2011, pp. 189-93
La violenza contro le detenute: nelle caserme, nelle carceri e nei Cie, in Zero Violenza Donne, 22 marzo 2011.
Poi anche in Quaderno 7 allegato a Scarceranda 2012, autoproduzione, Roma 2011, pp. 65-70 [file pdf]
‘Dubbing di Diaspora’: Gender and Reggae Music inna Babylon, in «Social Identities. Journal for the Study of Race, Nation and Culture», special issue on Postcolonial Europe: Transcultural and Multidisciplinary Perspectives, edited by Sandra Ponzanesi and Bolette Blaagaard, vol. 17, n. 1, 2011, pp. 137-152.
Poi anche in Sandra Ponzanesi, Bolette Blaagaard (eds.), Deconstructing Europe. Postcolonial Perspectives, Routledge, London 2011, pp. 137-152 (file pdf)
Quando la subalterna parla. Le Traiettorie di sguardi di Geneviève Makaping, in Roberto de Robertis (a cura di), Fuori centro. Percorsi postcoloniali nella letteratura italiana, Aracne, Roma 2010, pp. 131-48
L’eredità del colonialismo nelle rappresentazioni contemporanee del corpo femminile nero, in «Zapruder. Storie in movimento», Brava gente. Memoria e rappresentazioni del colonialismo, a cura di Elena Petricola e Andrea Tappi, n. 23, settembre-dicembre 2010, pp. 106-15
Voci e sguardi di donne, con Francesca Rinaldi, in «DWF – donnawomanfemme», Modelli femminili, n. 3-4 (87-88), 2010, pp. 3-10
traduzione di Chiara Bonfiglioli, Intersezioni di razzismo e sessismo nell’Italia contemporanea. Una cartografia critica dei recenti dibattiti femministi, in «DWF – donnawomanfemme», Modelli femminili, n. 3-4(87-88), 2010, pp. 64-76 (ed. or. Intersections of racism and sexism in contemporary Italy: A critical cartography of recent feminist debates, in «darkmatter», n. 6, 10 Oct. 2010)
«Ci chiamano “ospiti” ma siamo detenuti». I Centri di identificazione ed espulsione (Cie) ai tempi del “pacchetto sicurezza”, con la redazione di Silenzio Assordante, in Quaderno 6 allegato a Scarceranda 2011, 2010, pp. 5-19
Dal margine al centro. Le «Traiettorie di sguardi» di Geneviève Makaping, in La letteratura degli italiani. Centri e periferie, Atti del XIII Congresso dell’Associazione degli Italianisti Italiani (ADI), Pugnochiuso (Foggia), 16-19 settembre 2009, a cura di D. Cofano e S. Valerio, Edizioni del Rosone, Foggia 2011
Il sociale e il politico. Intervista a David Hilliard (Black Panther Party), con la redazione di Attica Blues, in «Infoxoa», n. 21, giugno 2008, pp. 54-8
La musica di Mery e Hasib, in «Infoxoa», n. 21, giugno 2008, pp. 120-1
traduzione di Rutvica Andrijasevic, Bei corpi morti. Genere, migrazione e rappresentazione nelle campagne contro la tratta, con Tiziana Mancinelli, in http://www.sguardisulledifferenze.org, 2009 (ed. or. Beautiful dead bodies: gender, migration and representation in anti-trafficking campaigns, in «Feminist Review», n. 86, 2007, pp. 24-44)
Scrittrici eccentriche. Generi e genealogie nella letteratura italiana della migrazione, in Alessia Ronchetti, Serena Sapegno (a cura di), Dentro/Fuori – Sopra/Sotto. Critica femminista e canone letterario negli studi di italianistica, Longo, Ravenna 2007, pp. 171-9
Introduzione alla letteratura italiana della migrazione, in Alfabetica: la parola come luogo d’incontro, a cura di Tullio Bugari, Gei, Jesi 2007, pp. 13-23
Vibrazioni da altrove. Un’inchiesta sulla musica dei migranti in Italia, in Armando Gnisci (a cura di), Nuovo Planetario Italiano. Geografia e antologia della letteratura della migrazione in Italia e in Europa, Città aperta, Troina 2006, pp. 519-37
La letteratura italiana di fronte alla sfida delle differenze, in «Jesi e la sua valle», n. 13, luglio 2006, pp. 30-1
L’insofferenza dei confini. L’opera di Jarmila Očkayová tra critica femminista e letteratura migrante, in Alessandro Amenta e Laura Quercioli Mincer (a cura di), Omosessualità e Europa. Culture, istituzioni, società a confronto, Lithos, Roma 2006, pp. 71-84
Quando il reggae è donna, in «Il Paese delle donne», maggio 2006, http://www.womenews.net
recensione di Mia Lecomte (a cura di), Ai confini del verso. Poesia della migrazione in italiano (Le Lettere 2006), in «pagine», Quadrimestrale di poesia internazionale, Anno XVI, numero 49, novembre-dicembre 2006, p. 45
Transnational Identities and the Subversion of the Italian Language in Geneviève Makaping, Christiana de Caldas Brito, and Jarmila Očkayová, in «Dialectical Anthropology», special issue on Trading Cultures: Migration and Multiculturalism in Contemporary Europe, edited by Gerald Pirog and Caterina Romeo, vol. 29, n. 3-4, September 2005, pp. 439-51
traduzione di Stuart Hall, Identità culturale e diaspora, in «Sagarana» n. 18, gennaio 2005 (ed. or. Cultural Identity and Diaspora, in Patrick Williams e Laura Chrisman, eds., Colonial Discourse and Post-colonial Theory. A Reader, Harvester/Wheatsheaf, 1993, pp. 392-403)
Il reggae è davvero solo un affare di uomini?, con Women in Reggae, in «Infoxoa», n. 19, marzo 2005, pp. 111-4
Lingua e identità in tre autrici migranti, in «Quaderni del ‘900», numero monografico su La letteratura postcoloniale italiana: dalla letteratura d’immigrazione all’incontro con l’altro, a cura di Tiziana Morosetti, Anno IV, 2004, n. 4, pp. 55-66
Scrittrici eccentriche. Identità transnazionali nella letteratura italiana, tesi di dottorato in Storia delle scritture femminili/Studi di genere, Sapienza Università di Roma, 2004
resoconto della Quinta conferenza europea di ricerca femminista. Gender and Power in the New Europe: intersections of ethnicity, class, disability, sexualities and generations, Lund (Svezia, 19-24 agosto 2003), in «Genesis», n. II/2, 2003, pp. 233-238
recensione di Rocco Paternostro, Salvatore Quasimodo o della poesia come etica, in «l’Abaco», Anno II, n. 2-3, 2003-4, pp. 256-8
recensione di Scrittori di fronte alla guerra, Atti delle giornate di studio, a cura di Maurizio Fiorilla e Valentina Gallo, in «l’Abaco», Anno II, n. 2-3, 2003-4, pp. 237-41
traduzione di Sandra Ponzanesi, Il multiculturalismo italiano, in «Sagarana», n. 10, gennaio 2003 (ed. or. Italian Multiculturalism, in Ead., Paradoxes of Post-colonial Culture. Feminism and Diaspora in South-Asian and Afro-Italian Women’s Narratives, tesi di dottorato, Utrecht 1999, pp.187-205)
resoconto del convegno Storiche di ieri e di oggi. Esperienze a confronto, in «Genesis», n. I/1, 2002, pp. 283-290
Laboratorio di Letture «Sguardo sulle differenze», con Maria Serena Sapegno, Monica Storini, Fabrizia Giuliani e le altre del «Laboratorio», in «DWF – donnawomanfemme», Spazio, n. 3-4, 2002, pp. 89-126 (il contributo di Sonia Sabelli è alle pp. 122-3)
recensione di Roberto Salsano, L’immagine e la smorfia. Rosso di San Secondo e dintorni, in «l’Abaco», Anno I, n. 1, 2002, pp. 237-9
recensione di The Craft and the Fury. Essays in Memory of Glauco Cambon, «Italiana» IX, a cura di Joseph Francese, in «l’Abaco», Anno I, n. 1, 2002, pp. 235-6
recensione di Pluralism & Critical Practice. Essays in Honour of Albert N. Mancini, «Italiana» VIII, a cura di Paolo A. Giordano e Anthony Julian Tamburri, in «l’Abaco», Anno I, n. 1, 2002, pp. 229-30
recensione di Paolo Segneri: un classico della tradizione cristiana, Atti del Convegno internazionale, in «l’Abaco», Anno I, n. 1, 2002, pp. 223-8
recensione di Giovanni Delfino, Nuove rime scelte, a cura di Rocco Paternostro, in «l’Abaco», Anno I, n. 1, 2002, pp. 221-3
Le Fiabe italiane di Calvino tra oralità e scrittura, in «Linguistica e letteratura», Anno XXVI/1-2, 2001, pp. 143-93
Le Fiabe italiane di Italo Calvino tra oralità e scrittura, tesi di laurea, facoltà di lettere, Sapienza Università di Roma, 2000